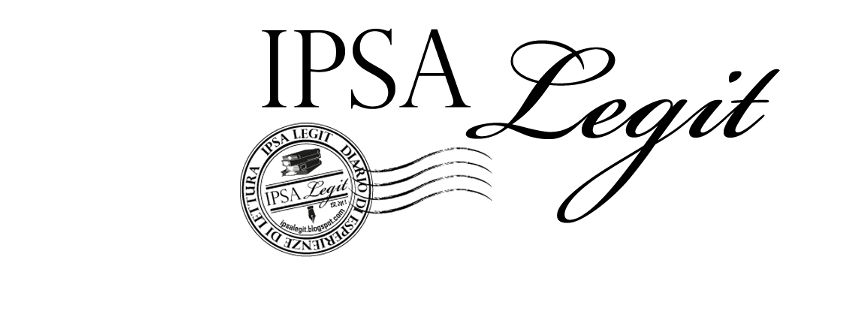Non leggevo Hemingway da tantissimi anni, ma rientrare nella sua scrittura con Festa mobile è stato come fare una passeggiata nel vento. Un’esperienza limpida, corroborante. Il libro è un’autobiografia giovanile in cui lo scrittore racconta il periodo vissuto con la prima moglie a Parigi. La “società” che Hemingway frequentava allora, tra una brasserie e un cafè della Riva Sinistra della Senna, era popolata di geni letterari (Pound, Ford, Joyce, Stein, Scott Fitzgerald, cui è dedicato un capitolo eccezionale), eppure le descrizioni delle sue solitudini sono ancora più vivide, perché legate a filo doppio con il valore quasi sacro della produzione letteraria.
«Tutta Parigi mi appartiene e io appartengo a questo quaderno e a questa matita» esordisce l’io narrante, aprendoci una finestra (e me la immagino, non so perché, affacciata su un prato spazzato dal vento) sul processo della sua creatività. «Restavo a guardare fuori, sui tetti di Parigi, e a pensare: “Non preoccuparti. Hai sempre scritto prima e scriverai adesso. Non devi far altro che scrivere una sola frase vera. Scrivi la frase più vera che conosci.” […] Lassù in quella stanza decisi che avrei scritto una storia su ogni cosa che conoscevo». Una sorta di mantra, che prodigiosamente riassume tutta la grandezza della scrittura di Hemingway: leggendo queste parole ci passano davanti agli occhi le scene di Fiesta, di Addio alle armi, di Per chi suona la campana, di Verdi colline d’Africa, dei racconti, che sprigionano proprio la potenza del conosciuto, dello sperimentato.
In Festa mobile l’attaccamento quasi passionale a Parigi ci rivela la convinzione che un luogo è denso non solo di significati – storici o emozionali che siano – ma anche di una sua inequivocabile identità. Come scrive Corrado Augias in I segreti di Parigi, «Vedere non è capire, anzi vedere può essere quasi niente se l’atto fisico del guardare non si accompagna alla consapevolezza della possibile dimensione latente degli oggetti». Joseph Conrad diceva che con la letteratura egli voleva non solo comunicare dei fatti, ma proprio «farli vedere» ai suoi lettori («My task, which I am trying to achieve is, by the power of the written word, to make you hear, to make you feel – it is, before all, to make you see» scrive in Lord Jim): questo è anche il talento di Hemingway, che con la parola sa trasportarci materialmente nei luoghi e fra le persone.
 |
| La Shakespeare & Co. (2010) |
Ci sembra di stargli accanto quando beve il suo cafè creme, quando osserva i pescatori dopo aver finito di scrivere, quando visita la libreria di Sylvia Blythe, la Shakespeare & Co.: «A quei tempi non c’erano soldi per comprare i libri. I libri li prendevo in prestito alla biblioteca circolante della Shakespeare and Company, che era la biblioteca e libreria di Sylvia Beach al 12 di rue de l’Odéon. In una via fredda e spazzata dal vento era un posto simpatico, caldo e accogliente, con un grande camino in inverno, tavoli e scaffali di libri, libri nuovi in vetrina, e al muro fotografie di famosi scrittori sia morti che viventi». Oppure quando, insieme alla moglie, attraversa i Giardini del Luxembourg, e «gli alberi erano bellissimi senza le foglie, una volta che ti riconciliavi con loro e i venti d’inverno soffiavano sulla superficie degli stagni e le fontane zampillavano nella luce chiara.»
E poi, come sempre, Hemingway è lo scrittore che più di tanti altri sa dare voce all’energia, alle speranze e alle difficoltà del mestiere di essere giovani: «Ma Parigi era una città molto vecchia e noi eravamo giovani, e lì non c’era niente di facile, neanche la miseria, né i soldi improvvisi, né la ragione, il torto, né il respiro di qualcuno sdraiato al tuo fianco al chiaro di luna.» E nonostante tutto, come egli scrisse in una lettera: «Se hai avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, dopo, ovunque tu passi il resto della tua vita, essa ti accompagna, perché Parigi è una festa mobile».